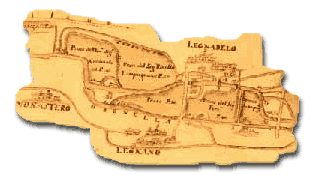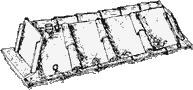Profilo Storico Dialetto Cittadini Benemeriti
Profilo Storico
"Fra tutte le città della Lombardia Milano è lodata come la rosa o il giglio fra i fiori, come il cedro nel Libano, come il leone fra i quadrupedi, come l'aquila fra gli uccelli, sì da apparire come il sole tra i corpi celesti, per la fertilità del suolo e la disponibilità dei beni occorrenti agli uomini".
Tale è la descrizione effettuata nel sec. XIII da Fra Bonvesin da la Riva "Ke sta im borgo Legnian", appartenente all'Ordine degli Umiliati, che si ritiene abbia insegnato grammatica a Legnano, al cui ospedale di S. Erasmo legò parte della sua sostanza.
Tra i borghi che fecero degna corona a Milano nella lontananza dei tempi, tra l'alternanza delle passioni e il luccicare delle armi, troviamo Legnano, situata sulla riva dell'Olona che la divide da Legnanello, con le spalle addossate all'attuale statale del Sempione e con le braccia protese all'interno già produttivo in biade, gelsi, fieni e buoni vini.
Origine del nome
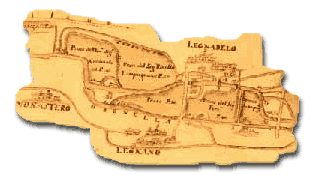
È stata avanzata l'ipotesi che "Legnano" debba identificarsi con la Liciniacum dei Latini, così chiamata dal console Lucio Licinio Crasso.
Altri ritengono che il nucleo originario dell'attuale città fosse formato da agricoltori i quali, trovato un terreno fertile, costruirono le loro primitive abitazioni sulle rive dell'Olona, costretti a difendersi dai lupi annidati nei boschi vicini e ancora presenti nella zona durante la prima metà dell'Ottocento.
Non mancano quelli che hanno definito Legnano come Vicus agri Sepriensis, cioè come un villaggio del Seprio, del cui comitato faceva parte e come attestato dal largo omonimo.
Nelle antiche carte la denominazione varia da Liniano, Livian, Legniano e in dialetto Legnàn e pr. esso Legnarell, alterato da Legnanell.
Si pensa anche a Ledegnanum, da rifiutare però perché riferito a località forse oltre il Po. Suggestiva, ma puro frutto di fantasia e da scartare la derivazione da lignum anus o legno della vecchia.
Secondo il dizionario toponomastico dell'Olivieri, prima del 1000 Legnano era detta Lemnianum, diventato Legnanum nelle Gesta Friderici imperatoris.
Sulla base di questo accostamento si può pensare a un personale romano Limenius / Laenius.
Antichità
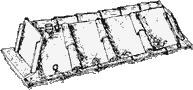
Etimologia a parte, l'antichità del borgo è fuori discussione. Ne fanno fede i ritrovamenti archeologici, ora dovuti a scavi per costruzione di edifici, ora a una esplorazione sistematica del territorio.
Le più antiche tracce della presenza umana sul territorio legnanese sono fornite da pochi frammenti di un vaso a forma di campana rinvenuti tra il 1926 e il 1928 nella zona della Montagnola, risalenti alla cultura di Remedello (fine 2000-1800 a.C.).
Da corredi gallici di corso Sempione sono emersi bronzi, vasi della cultura di La Tène (IV-I sec. a. C.). Importanti i reperti romani tratti nel 1925 dalla necropoli di via Novara.
Si tratta di monete, piatti, coppe, bicchieri, balsamari, specchi, utensili in ferro. Altre sepolture sono venute alla luce nel 1985 in via P. Micca e nel 1991 durante i restauri della chiesa di S. Ambrogio.
La tarda età romana è documentata in Legnano e dintorni da sepolture alla cappuccina con rito inumatorio.
Il corredo è costituito da olpi, ciottoli, coltelli, rasoi, fibbie. Tutto il materiale è conservato al Museo Sutermeister.
Prima documentazione
La prima sicura traccia storica risale al 789. Si tratta di un atto di cessione di una corte sita in Leunianello fatta da Pietro, arcivescovo di Milano, al monastero di S. Ambrogio. Documento importante non solo perché ci segnala la comparsa del toponimo, ma anche perché testimonia dei rapporti con l'autorità religiosa. Inserita nel Seprio, Legnano ne seguì di riflesso le vicende, tenuto conto della crescita di potere dell'arcivescovo che non era solo un ecclesiastico, ma anche un capo civile e militare. Legnano fu quasi certamente coinvolta nelle lotte di carattere religioso e sociale che videro S. Arialdo aggirarsi per le campagne e infiammare con la sua predicazione le popolazioni contro l'arcivescovo Guido da Velate, finché questi dovette rifugiarsi nel fortilizio posseduto in città da Erlembaldo Cotta. Non è rimasto traccia del castello, ma l'arcivescovo milanese accrebbe il potere sul borgo tramite i grandi monasteri. Della forza di questi testimonia un atto del 1148, in cui si accenna a beni posseduti in Legnano dalla badessa di S. Maurizio di Milano.
Dalla battaglia del 1176 al Cinquecento
Fatti e leggende si intrecciano nella descrizione dello scontro avvenuto il 29 maggio 1176 tra le forze della Lega e le truppe di Federico I. Dopo un avvio negativo, nella seconda fase della lotta gli uomini della Lega, rinserratisi attorno al carroccio, grazie anche all'arrivo di truppe fresche di rinforzo, riuscirono a respingere l'attacco avversario e a costringere alla fuga il Barbarossa.
Colorito, sia pure con qualche indulgenza alla fantasia, il racconto della battaglia, effettuato nel sec. XIV dal domenicano Galvano Fiamma che fece di Alberto da Giussano un simbolo di grandezza e di valore. A quest'ultimo fu dedicato, dopo il VII Centenario della battaglia, il monumento opera del Buzzi, destinato a sorgere inizialmente in una zona vicina alla chiesa di S. Maria delle Grazie.
Il nome di Legnano ritorna costantemente alla ribalta nel sec. XIII con l'arcivescovo Leone da Perego, che morì nel 1259 in città, arricchita poi di un altro prezioso palazzo da Ottone Visconti, al quale è fatta risalire la costruzione della maggior parte del Castello. Questo, attorno al 1437, fu donato da Filippo Maria Visconti a Oldrado Lampugnani, che lo fece restaurare nel 1448, dopo il saccheggio subito da parte di Francesco Sforza.
Ereditato dall'Ospedale Maggiore di Milano, ceduto da questi ai Cornaggia, il Castello è passato definitivamente al Comune dopo la seconda guerra mondiale.
Sul piano strettamente religioso interessa segnalare a Legnano, nel 1300 la presenza di diverse chiese, tra le quali importanti quelle di S. Ambrogio, S. Martino, S. Salvatore, S. Maria, S. Agnese, S. Nazaro, per non parlare di una casa di Umiliati esistente già nel 1298. A loro si deve la fioritura dell'industria della lana. Risultato eloquente fu dato dalla costituzione delle classi dei mercanti imprenditori che, acquistata la materia prima, l'affidavano per la lavorazione ad operai specializzati. La matricola dei mercanti del 1393 registra l'iscrizione dei vari Ambroxinus, Antonius, Antoninus, Bernardinus, Francischus, Galeaz de Legnano, con i relativi marchi impressi sui prodotti.
Tutte le chiese rientravano nella pieve di Olgiate Olona, trasferita poi a Busto Arsizio (dal cui distretto Legnano dipendeva in civilibus), finché Legnano stessa divenne capopieve nel 1584, per l'accresciuta importanza economica e per l'eccellenza della sua basilica.
Minacciata nel 1303 da Cressone Crivelli che inutilmente cercò di occuparla, nel 1339 Legnano vide piazzare le tende di Lodrisio Visconti nel tentativo non riuscito di spodestare Azzo Visconti, Signore di Milano che, con l'aiuto dello zio Luchino, lo battè nella battaglia di Para iago.
L'epoca viscontea-sforzesca rappresentò dunque per Legnano una stagione di florido sviluppo economico basato sull'agricoltura favorita dalla presenza di mulini appartenenti a famiglie nobili e alla Mensa arcivescovile milanese; ma anche sostenuto da una discreta attività commerciale. A darle ulteriore rinomanza provvide Giovanni Oldrendi, illustre canonista, notaio, autore di numerosi trattati di carattere giuridico, scientifico, sociale, religioso, Vicario del papa, professore all'università di Bologna, di cui fu Podestà e dove mori nel 1383, compianto da tutta la popolazione. Toccò a lui rogare l'atto di acquisto della città, ceduta dai Pepoli ai Visconti, che ne volevano fare l'epicentro di una confederazione da opporre a Firenze e a Venezia.
Nel periodo compreso tra la metà del 1400 e quella del 1600 Legnano annoverò molte famiglie nobili, tra cui i Visconti, i Borromeo, i Crivelli, i Bossi, i Vismara, i Lampugnani. Di questi ultimi piace ricordare il maniero di Legnanello dalla caratteristica eco simile a quella di Villa Simonetta a Milano; ma anche le imprese del cavaliere di Malta, Giuseppe Lampugnani che, con un seguito numeroso di bravi, terrorizzava la zona, tanto da costringere il Vicario del Seprio ad emanare nel 1647 un bando contro di lui, con il quale gli si comminava una pena di duemila scudi qualora non si fosse astenuto dal compiere misfatti nel peggiore disprezzo della giustizia.
Tentativo di infeudazione
Il 1500 si apre con il completamento della basilica di San Magno, attuato tra il 1512/13, quasi a compensare il sacco operato due anni prima dalle truppe di M. Schinner. Crebbe intanto la popolazione arrivata a circa 2500 anime, verso la fine del secolo. Da ricordare che nel 1583 i terrieri della zona verso S. Giorgio decisero di costruire, in sostituzione di una cappella già esistente alla fine del 1400, una chiesetta dedicata alla Vergine che oggi va sotto il nome di S. Maria delle Grazie.
L'atmosfera fu però turbata dagli scoppi a ripetizione della peste e dal bando di infeudazione emesso dai dominatori spagnoli, sventato nel 1652 dal versamento di L. 6680 effettuato da B. Lampugnani per riscattare i 258 focolari esistenti.
Legnano e i Comunetti del 1700
Sotto la dominazione austriaca fu avviato il riordino del catasto e anche le proprietà di Legnano furono suddivise in beni di prima stazione comprendenti i terreni prevalentemente di tipo aratorio vitato; e di seconda stazione relativi alle case. Con la tavoletta pretoria, così chiamata dal suo inventore, furono redatte mappe gigantesche misurate in trabucchi. Legnano risultò divisa in nove Comunetti dotati di amministrazione autonoma:
Dominante, Lampugnani, Morosino grande, Morosinetto, Personale, R. R. Monache di Legnano, Trotti, Visconti, Vismara.
Verso la fine del secolo l'imperatore Giuseppe II visitò Legnano e il suo pellagrosario allestito nel soppresso convento di S. Chiara e affidato alle cure del Dr. Strambio.
A prova dell'attività commerciale sta la concessione del mercato settimanale autorizzato nel 1795, dopo le richieste presentate nel 1499 a Ludovico il Moro, nel 1627 a Filippo IV.
Sviluppo ottocentesco
Con l'inizio dell'Ottocento iniziò per Legnano una fase di trasformazione graduale che segnò il passaggio al ruolo di città assunto nel 1924.
Ricordato che alla metà del 1500 commerciavano in cotone i Cornacchia soci dei Prata, da un rapporto del 1807 deduciamo che in Legnano esistevano filature di seta, di cotone sia pure esercitate in forma artigianale ed uscite dall'anonimato nel 1821 con lo svizzero C. Martin, che impiegava 200 operai nel 1863.
Lo spirito di intraprendenza e l'entità dei capitali impiegati, la disponibilità di mano d'opera a baso prezzo favorirono l'apertura delle filature Krumm, Borgomaneri, degli stabilimenti Fr. Dell'Acqua (1871), A. Bernocchi (1872/73), De Angeli (1875), del Cotonificio Cantoni (1879). Da questo ultimo venne F. Tosi fondatore dell'omonima officina nel 1882.
Rallentato il ritmo produttivo periodicamente a causa dello scoppio del colera (1836), del tifo, del vaiolo (1887), i Legnanesi diedero il loro contributo per il riscatto dalla dominazione autriaca, con patrioti come Saule Banfi ed Ester Cuttica e salutarono festosamente Garibaldi presente nel 1862.
Naturale il sostegno dato alle industrie legnanesi dagli Istituti di credito come la Banca di Legnano (1887), dal Credito Legnanese (1923), dalla attivazione della ferrovia Milano-Gallarate (1860), dalla tramvia Milano-Legnano (1880).
Dalla prima alla seconda guerra mondiale
Allo sviluppo industriale si accompagnarono nel 1900 l'aumento della popolazione e la trasformazione del centro abitato, arricchito da nuovi edifici. Nei primi anni fu avviata la costruzione del nuovo Ospedale, fu inaugurata la nuova sede del Municipio (1909), già disposta in una casa di proprietà Cornaggia.
Dopo il primo conflitto mondiale, al quale i Legnanesi diedero un grosso contributo di sangue, difficile, ma graduale la ripresa economica accompagnata dalle elezioni del 1919 che assicurarono la vittoria al Partito Socialista.
Quindi l'avvento al potere del fascismo, con la visita di Mussolini a Legnano, nel 1924, per l'inaugurazione della Scuola di Avviamento al lavoro A. Bernocchi che, con l'Istituto Tecnico C. Dell'Acqua (nato nel 1917) favorì il cammino ascensionale scolastico, dopo la nascita di istituzioni private, la prima delle quali risaliva all'epoca di S.Carlo.
Data dal 1935 l'inizio delle manifestazioni della Sagra del Carroccio, interrotta durante il secondo conflitto e ripresa nel 1952.
Quindi il verificarsi della seconda guerra mondiale con i suoi drammatici avvenimenti segnati da bombardamenti, scioperi, arresti, deportazioni e dal costituirsi di gruppi clandestini fino all'azione dell'aprile 1945, nel corso della quale furono sbaragliati i vari presidi fascisti e tedeschi, dopo di che il CNL assicurò il controllo della città. L'albo delle medaglie d'oro, dopo A. Robino, C. Borsani, R. Achilli, si arricchì del nome di M. Venegoni.
Il moderno cammino ascensionale
Ritornata la pace, ripristinati i poteri democratici con le elezioni amministrative che videro A. Tenconi come primo Sindaco della Liberazione, riprese a girare il motore della produzione. L'artigianato costituì un valido supporto alle maggiori aziende; notevole lo sviluppo del settore terziario.
Nel 1951 fu avviata una nuova politica urbanistica che però stentò a decollare, perché il piano regolatore subì continue modifiche e integrazioni per l'individuazione di nuovi quartieri in espansione, nelle zone di Canazza e Mazzafame. Intorno agli anni Sessanta Legnano cambiò volto, con la copertura di un ramo dell'Olona, la creazione del viale Toselli, la soppressione della tramvia, la costituzione di un grattacielo, la lottizzazione di terreni già occupati da vecchi stabilimenti, per potervi costruire nuove abitazioni. Le scuole dell'obbligo già affiancate dall'Istituto privato Magistrale B. Melzi (1854), dal Liceo Scientifico (1943), si accrebbero del Classico nel 1960.
Tra le associazioni, punto naturale di riferimento la Famiglia Legnanese, all'avanguardia per la promozione di svariate iniziative; la Società Arte e Storia; il Museo Sutermeister. Ai bisogni sociali corrispondono due case per anziani, a quelli culturali la Biblioteca civica.
Certamente tutto questo non costituisce un Paradiso, a causa del calo sensibile della produzione, dello squilibrio fra potenziale produttivo e capacità di assorbimento del mercato. Rimane l'augurio che, alle soglie del Duemila, la cultura imprenditoriale escogiti nuove strutture organizzative, riproponga meccanismi che consentano di rilanciare il sistema produttivo.
autore Egidio Gianazza
TOP
Dialetto
Ai tempi della mia fanciullezza sentivo attorno a me da mattina a sera risuonare la nostra favella, da tutti ritenuta "brutta" ma inevitabile nelle conversazioni normali di modesto contenuto culturale. L'italiano stava nei giornali, nei libri stampati e piuttosto malconcio nelle rare lettere che si scrivevano a persone lontane, non tanto perché i destinatari non capivano il dialetto, quanto perchè nessuno sapeva come scriverlo (ancor oggi, quanti lo sanno o lo saprebbero?).
Lo stesso dialetto non era uguale per tutti. Nell'ambiente contadino il "tetto" e il "letto" si dicevano teciu, leciu ma al plurale tici e lici. Al centro del borgo invece si pronunciavano tec e let. Poche famiglie distinte usavano per una loro tradizione più signorile, il milanese. E quando un legnanese doveva usare l'italiano parlando con un forestiero o leggendo un testo ad alta voce, immetteva nell'italiano i suoni più cupi del dialetto come quelle a oscure che in questo libro sono indicate con un circoletto sopra la vocale.
Mia madre mi ricordava le prediche del prevosto Gianni in S. Magno (fine Ottocento) quando diceva citando la Bibbia: "Sia fatta la lùce e la luce fù" (colle ù lombarde). Oggi io sento ragazzi e ragazze che parlano un fluido italiano senza inflessioni dialettali (salvo quelle comuni a tutti i lombardi, come bene colla e; chiusa e tre colla e aperta). È l'effetto di una rivoluzione e di un progresso culturale dovuto a una più lunga frequentazione scolastica, letture più frequenti e soprattutto, direi, per la prese nza assidua in ogni famiglia di un personaggio nuovo che e il televisore.
Tanto il teatro dialettale di Musazzi come il recente vocabolario del dialetto legnanese a cura di Giorgio D’Ilario, non intendono dunque insegnare un linguaggio ormai sconosciuto o rifiutato da quasi tutti. Vogliono essere un omaggio alla nostra storia registrando un certo numero di parole, alcune delle quali sono scomparse anche dalla memoria. Per esempio il termine rasciùm per dire "arcobaleno" e sparito dalla circolazione ancor prima degli anni Cinquanta, quando mori l'ultima donna che lo sapeva (e ancora vivo forse nel Canton Ticino). So bene che esiste un movimento di opinione che vorrebbe "salvare" il dialetto come si cerca di salvare qualche pianta o animale in via di estinzione. Ma per salvare una pianta o una bestia è sufficiente ricreare un certo ambiente naturale, dove per esempio un orso potrebbe continuare a vivere come per millenni sono vissuti i suoi antenati, invece per salvare il dialetto bisognerebbe retrocedere al livello cultura le dei contadini legnanesi dell'Ottocento.
Una lingua e il riflesso di una cultura e richiede che tutti i membri di una comunità la conoscano e la parlino. In certi luoghi si tenta di insegnare il dialetto locale ai bambini delle scuole elementari allo scopo di tener vive le radici culturali del paese. A parte la difficoltà di trovare insegnanti esperti evitando che una maestrina calabrese pretenda di insegnare che dire? il bustocco ai figli dei sardi o dei veneti immigrati, resta il fatto che in città come la nostra i cui abitanti sono giunti da ogni regione d'Italia, è assurdo che un oriundo napoletano debba cercare le proprie radici nel dialetto di Legnano.
Ci sono correnti politiche che pur di frantumare l'unità nazionale, propongono di sostituire l'italiano col dialetto regionale prima di sceglierne uno fra la miriade di dialetti spesso fra loro incomprensibili. (Mi dicono che a Dairago la segnaletica stradale presenti un Dairag quando si sa che in dialetto il paese si chiama Daiagu.
È ovvio riconoscere che in tutta Italia la situazione linguistica è diversa da quella di Legnano e di tante altre città, ma il dialetto e sempre un'isola priva di comunicazione col resto della Nazione.
E interessante ricordare la presenza di un sostrato ligure nei dialetti attorno a Legnano e Busto Arsizio. Non si tratta di contatti fra i nostri paesi e quelli affacciati sul mar Ligure. I fatti risalgono alla preistoria, quando le terre dal Rodano alla vai Camonica erano abitate da tribù liguri. Il loro linguaggio nella seconda metà del primo millennio a. C. fu trasformato prima dalla dominazione gallica, che non penetrò dappertutto in egual misura, poi da quella più profonda e decisiva dei Romani. I Liguri più tenaci rifugiati sui monti che presero il nome di Liguria, conservarono certe loro caratteristiche culturali. Io credo che l'influsso dei Galli abbia diffuso una tendenza a contrarre le parole latine, quando anch'essi si convinsero ad abbandonare la propria lingua e adottare quella dei dominatori Romani. Allora molte parole perdettero gradatamente le vocali non accentate (a Bologna "hospitale" si è ridotto a sbdel). Chi abitava sui monti della Liguria non avendo subito una celtizzazione profonda si sottrasse, almeno in parte, a quella tendenza e così avvenne per una tribù incu neata lungo l'Olona tra la brughiera a Ovest e i boschi a Est verso Tradate-Saronno. Perciò parole come lectu, lacte all'interno di quella zona divennero leciu e laci, all'esterno invece lec' e lac' (e così tantissime altre parole). La presenza di una vocale, e quindi di una sillaba in più imprime un ritmo diverso alla parlata.
Un altro fenomeno comune coi Liguri riguarda l'indebolimento e il dileguo di r tra due vocali. Esso non riguarda Legnano e la sua pieve ma soltanto le pievi di Busto Arsizio e Dairago. Di qui il contrasto Urona: Uona, dur: dùu, ecc.
Confrontato col milanese il dialetto di Legnano rivela affinità ma anche differenze profonde. La più importante è che essi rappresentano culture diverse. Cittadino e signorile il milanese, più povero e contadino il legnanese. Il primo si avvale anche di una tradizione letteraria e poetica, che a Legnano è sempre mancata, se si esclude qualche nostro contemporaneo. Ma la tradizione dei Maggi, Porta, Tessa ecc. ha un debito enorme colla letteratura italiana.
Ne La nomina del Cappellan la Marchesa dice: Avria suppost, che essendo Sacerdott Avesser un pò più d'educazion...
Un popolano non avrebbe mai usato "essendo", "suppost", "Sacerdott" che vengono dalla lingua italiana. Così dicasi della metrica che il Porta ha preso dalla letteratura nazionale e via dicendo.
I Legnanesi fino al secolo scorso erano contadini e artigiani analfabeti. Il lessico si riferiva alla vita familiare e a quella dei lavori agricoli, con una sintassi elementare. Una particolare attenzione va data ai suoni nasali, che spiccano nel milanese. In parole come be, bn (bene, buono) a Milano la consonante n non viene pronunciata, ma la vocale precedente ha una forte risonanza nasale. A Legnano invece bene si dice ben con n chiaramente articolata, buono si rinforza addirittura in m, bum. Solo la vocale più aperta a (per esempio pan, "pane") permette di tacere n mentre la a ha una debole nasalizzazione (ma io ricordo di aver sentito anche p an).
Non dovrei però insistere troppo sulla società contadina in cui si formò e visse il dialetto legnanese, perché la rivoluzione industriale già dal secolo scorso ha allontanato sempre più gli uomini dalla terra rinchiudendoli nelle fabbriche. La casa contadina coll'abitazione in procinto della strada e le stalle coi fienili in fondo alla corte è stata sostituita da una specie di alveare a diversi piani colle stanze tutte uguali collegate dal ballatolo (ringhiera o in legnanese ca da ringhera) come passaggio obbligato verso l'unica scala. Questo ambiente più popoloso, con difficili problemi di affiatamento e convivenza, è stato stupendamente rappresentato dal Teatro dei "Legnanesi" di Musazzi. lì "suono" del nostro dialetto vi risonava in modo perfetto. Probabilmente passando dal mondo contadino a quello operaio nei primi decenni di questo secolo il ritmo sarà diventato un pò più rapido, ma non più amabile o più leggiadro. Credo che quella gente non trovasse il tempo per contemplare le cose belle o un paesaggio (solo nelle giornate di vento e sgombre di nubi si vede da lontano il massiccio ghiacciato del Rosa) o di lasciare il paese per visitar hi più gradevoli. Il teatro dei "Legnanesi" risuonava di litigi, di proteste, di lamentele o di rabbia per le fatiche di un lavoro strenuo e scarsamente rimunerato. Oggi la società opulenta ha collocato nelle lontane memorie quel modo di esistere e contemporaneamente ha decretato la morte del dialetto.
di Augusto Marinoni (Dalla prefazione al "Vocabolario del dialetto legnanese", a cura di Giorgio D'Ilario, Legnano 1991).
TOP
Cittadini Benemeriti
Secondo quanto previsto dal Regolamento (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 10/06/2015), la benemerenza civica è un riconoscimento con il quale la Città di Legnano premia i legnanesi, singoli o associati, che si sono particolarmente distinti per attività ispirate ai fondamentali valori umani della solidarietà, della dedizione e dell'aiuto al prossimo, per il contributo dato al progresso della cultura in ogni campo del sapere, per il significativo apporto al miglioramento della qualità della vita e di convivenza sociale, conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella professione, nella produzione culturale e artistica, nella pratica o promozione delle discipline sportive, nella produzione di beni e nel commercio, nella gestione politica e amministrativa. In alcuni casi particolari è stato assegnato anche un premio speciale, denominato 'Albertino d'oro'.
La benemerenza viene conferita nel corso di una cerimonia che si svolge in occasione della ricorrenza del Santo Patrono (San Magno) il 5 novembre, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose.
L'elenco dei cittadini che sono stati insigniti di questo riconoscimento dall'anno 1981 fino ad oggi è disponibile al seguente link
TOP
 CONOSCERE IL COMUNE
CONOSCERE IL COMUNE
 Economia, Lavoro e Impresa
Economia, Lavoro e Impresa
 Servizio Tributi
Servizio Tributi
 Servizi Demografici e Amministrativi
Servizi Demografici e Amministrativi
 Polizia Locale - Sicurezza e Mobilità
Polizia Locale - Sicurezza e Mobilità
 Servizi per le Persone, le Famiglie e le Donne
Servizi per le Persone, le Famiglie e le Donne
 Ambiente, Verde e Raccolta Differenziata
Ambiente, Verde e Raccolta Differenziata
 Scuole e Formazione
Scuole e Formazione
 Urbanistica - Casa e Territorio
Urbanistica - Casa e Territorio
 Servizi e Opere Pubbliche
Servizi e Opere Pubbliche
 Eventi, Sport e Tempo Libero
Eventi, Sport e Tempo Libero
 Partecipazione Sociale - Pari Opportunità
Partecipazione Sociale - Pari Opportunità
 Sistema Informativo Territoriale
Sistema Informativo Territoriale
 Cultura - Biblioteca - Museo
Cultura - Biblioteca - Museo